(Shahidul Alam)
 |
| Shahidul Alam. “Lokman”. Nanyang Technological University (NTU). Singapore, 1999 |
Ci sono alcuni fotografi con cui si prova una forte empatia, che nasce
dapprima dai libri e dalle loro fotografie e poi, se si ha la fortuna di
incontrarli di persona, viene confermata e rafforzata a pelle.
Così è stato con Shahidul Alam, il prossimo fotografo di cui vi voglio parlare.
Il suo libro “My Journey as a Witness”, del 2011, è stato uno dei
primissimi libri che comprai, perché era una rarità trovare libri fotografici
che raccontassero il Bangladesh, paese che fu una forte ispirazione nel mio
viaggio di fotografo, come ho già scritto molte volte.
Quel libro lo comprai perché era una porta che si apriva su un paese
che stavo iniziando a conoscere, e diventò la scoperta di un grandissimo
fotografo.
Shahidul Alam, nato nel 1955 a Dhaka, ha una storia personale complessa
ed un'attività intensa.
Non è facile riassumere tutto quello che ha fatto, non solo come
fotografo, ma in primo luogo come attivista per i diritti umani.
Shahidul Alam iniziò a fotografare quasi per coincidenza. Studente di
dottorato in chimica a Londra, Alam acquistò una Nikon FM per un amico durante
un viaggio negli Stati Uniti e in Canada nel 1980, ma l'amico non poteva
rimborsarlo, quindi ha tenuto la fotocamera.
“Ho iniziato a usarlo”, racconta Alam in un'intervista al TIME di Dhaka.
“È stato quando ho capito, lavorando come attivista sociale, quanto fossero
potenti le immagini, che ho deciso che sarei diventato un fotografo.”
 |
| Shahidul Alam con una famiglia Rohingya. Foto: Mohammad Shahnewaz Khan, 2017. |
Da allora nel 1989, ha co-fondato la Drik Picture Library con il suo
partner di lunga data, l'antropologo e scrittore Rahnuma Ahmed, per reclutare e
rappresentare i fotogiornalisti del Bangladesh e difendere la libertà di parola
nel suo paese. Nel 1998 ha fondato il Pathshala South Asian Media Institute,
un'accademia fotografica che ha laureato alcuni dei più interessanti e vincenti
giovani fotografi del suo paese, e nel 2000 Chobi Mela, il primo festival
internazionale di fotografia in Asia. È diventato la prima persona del Sud Est
Asiatico a presiedere la giuria del World Press Photo, nel 2003, e ha ricevuto
numerosi riconoscimenti, tra cui lo Shilpakala Padak, il più alto
riconoscimento artistico del Bangladesh.
Come ha scritto il grande Raghu Rai:
“In India abbiamo molti più fotografi, alcuni molto bravi, e ci sono molte gallerie d'arte e soprattutto di fotografia. Oltre a rinomati giornali e riviste, molto sta accadendo a molti livelli. Ma non abbiamo uno Shahidul Alam, che possa combinarli in una forza sociale e creativa coesa.”
Non è un caso che l'introduzione al suo libro è stata scritta da
Salgado.
Entrambi provenienti da quella parte del mondo che, lo stesso Alam, ha
chiamato il “Majority World”, per sostituire quel “Terzo Mondo” creato
dall'Occidente per mantenere certe differenze che sono ormai fuori dalla storia
reale delle nazioni e le loro geografie politiche.
Proprio per la sua attività in difesa dei diritti umani e della libertà
di parola e stampa fu arrestato, trascorrendo 107 giorni in carcere, finché una
petizione mondiale di artisti, fotografi, giornalisti e gente comune costrinse
il governo a liberarlo.
Alla sua detenzione è, in parte, dedicato il suo ultimo libro “The Tide
Will Turn”, del 2019, che prende il titolo dalla conclusione della lettera che
la scrittrice indiana Arundhati Roy gli scrisse quando era in carcere.
Un libro molto intenso e privato, che mostra non solo i suoi giorni in carcere,
ma anche le battaglie che ha portato avanti negli anni come quella per la
giovane studentessa Kalpana Chakma, scomparsa nel giugno del 1996, perché
difendeva in modo risoluto i diritti delle popolazioni tribali delle Chittagong
Hills dai soprusi del governo.
Alam ha ripercorso la sua vita e i suoi ultimi momenti, come un
fotografo della polizia scientifica – con accuratezza e tanta pietà.
Appena sono arrivato a Dhaka, lo scorso febbraio, ho avuto subito nelle
mie intenzioni quella di riuscire ad incontrare Shahidul Alam, e grazie anche
alla sua disponibilità e gentilezza, il sogno si è avverato, non molti giorni
prima della mia partenza.
Ci siamo incontrati nella sua accademia Pathshala, prima che
traslocasse nella nuova sede, e abbiamo scambiato i nostri libri. Mi ha
raccontato della sua scuola, delle sue attività. È stato un bel momento che non
dimenticherò; è fondamentale avere conferma di certe qualità umane che si
leggono nelle fotografie e che poi appartengono sinceramente anche alla
persona; troppo spesso le fotografie e le parole sono migliori delle persone
dietro la macchina fotografica.
Quello che colpisce di Alam e la sua attitudine e il suo sorriso
bonario.
Tante ne ha viste e sa come affrontare le tempeste.
Voglio sottolineare questo aspetto perché non capita spesso di potere
incontrare i propri miti.
 |
| Shahidul Alam. “Girl at Anwara”. Anwara, Bangladesh, 1991 |
Comunque, tornando a noi, in questo ultimo libro ci sono anche altre
immagini del suo lungo progetto “Migrant Soul”, che è uno di quelli che io amo
di più. Perché questo è stato uno degli elementi di forza che mi fece amare il
suo lavoro: non era solo una questione di immagini e volti che raccontavano il
Bangladesh, ma era anche focalizzato sul tema della migrazione, sulle
difficoltà del suo popolo costretto ad emigrare per sopravvivere, che è sempre
stato anche il mio comune interesse.
Fu inevitabile, perciò, che il suo primo libro diventò una pietra
miliare della mia libreria e dei miei corsi di Mediazione Culturale.
Inoltre, nella mia permanenza in Malesia, così come nei miei continui
viaggi in aereo, negli aeroporti di Doha o Abu Dhabi, ho rivisto con i miei
occhi i soggetti delle sue fotografie, tutti quei bangladesi che hanno lavorato
nei cantieri delle Petronas Towers in Kuala Lumpur del 1998, oppure i volti
stanchi e persi nel vuoto di chi attendeva un volo di ritorno negli aeroporti.
In ogni strada e cantiere della Malesia ci sono centinaia di lavoratori dal
Bangladesh, così come gli addetti alla pulizia degli aeroporti delle grandi e
ricche capitali arabe.
Ovviamente tacendo tutto quello che ho visto in oltre dieci anni con la
comunità bangladese a Roma.
 |
| Shahidul Alam. Maldive, 2000 |
 |
| Shahidul Alam. “Airport goodbye”. Dhaka airport. Bangladesh, 1996 |
Difficile scegliere una singola immagine.
Shahidul Alam ha iniziato a lavorare sul tema della migrazione dagli
anni 80 – come mi ha detto lui – e non ha ancora smesso.
Ma questa di Lokman a Singapore mi ha colpito da subito, per diversi
motivi.
Innanzitutto per l'impatto visivo, con questi bianchi e neri potenti in
controluce; per il senso di solitudine che emana questa immagine; e poi per le
parole dello stesso Lokman che Shahidul riporta nella didascalia:
“Ci sono ragazze del Bangladesh provenienti
da famiglie benestanti che studiano qui. Le sentiamo parlare tra loro in
bengalese, ma quando proviamo a parlare con loro fanno finta di non conoscere
la lingua.”
In questa poche righe, unite a questa fotografia, rendono veramente in
modo dirompente una condizione vissuta da migliaia di lavoratori all'estero.
Più di saggi da centinaia di pagine.
Secco e potente. Struggente.
La condizione di addetto alla pulizie che diventa una categoria esistenziale, non solo lavorativa. Ignorati e rifiutati, quasi con disgusto, dalle classi agiate del proprio popolo.
Questo mi è capito di avvertirlo molte volte anche qui in Italia.
Chi ha la fortuna di potere fare una vita migliore in un paese
straniero, tende a distogliere lo sguardo da chi, stesso sangue e paese,
ricorda loro da dove sono venuti. La superbia di chi preferisce ignorare la
parte scura della propria pelle. Di chi guarda dall'alto in basso e finge
addirittura di non conoscere la propria lingua, per non “mischiarsi”.
Proprio i bangladesi che sono morti per difendere la propria lingua,
fondando la loro nazione...
Ma Shahidul Alam no, lui non guarda dall'alto in basso. Da fotografo di
fama mondiale, da direttore di scuole e vincitore di premi.
No. Lui si abbassa, al livello del pavimento. Fotografa Lokman dal
suolo, cosicché la sua figura si innalzi, riprenda tutto il suo valore di
essere umano, di “eroe migrante” (bayani, viene detto in Tagalog, l'eroe
che parte dalle Filippine, sacrificando la sua vita all'estero per garantire
una vita migliore alla sua famiglia in patria).
In questa immagine c'è tutto l'amore e il rispetto di Alam per il suo
popolo, soprattutto la parte più debole e indifesa.
Le fotografie parlano e raccontano tanto se si è capaci di leggerle. Anche le prospettive e i punti di vista.
Nel suo essere inginocchiato davanti ad un addetto delle pulizie, nella sua solitudine, Shahidul Alam ci ha ricordato cosa significa il rispetto. Per i più deboli, per chi non ha voce.
Ed è per questo che in migliaia si sono mossi affinché fosse scarcerato. Affinché la sua voce non sia mai imbavagliata.
Così come i nostri occhi.
“La pace qui cerco, su questa sabbia e su questa terra,
questo posto dove sono nato”
(Shahidul Alam)
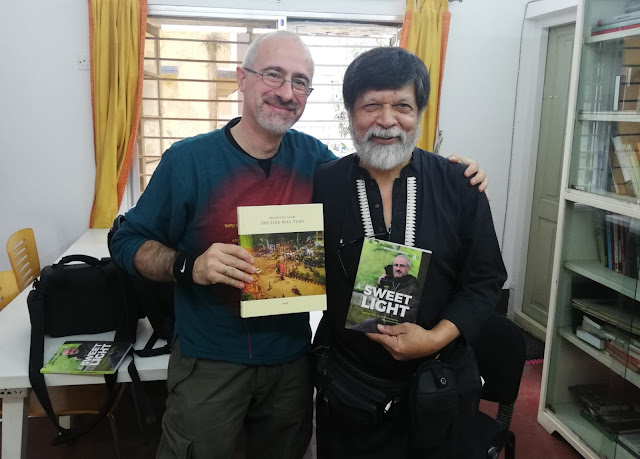 |
| Io e Shahidul Alam. Dhaka, Bangladesh, Febbraio 2020 |
READ ALSO:
Per vedere Migrant Soul: https://universes.art/en/nafas/articles/2009/shahidul-alam
Shahidul Alam: “My Journey as a Witness”(SKIRA, 2011)Shahidul Alam: “The Tide Will Turn” (Steidl, 2019)


Comments
Post a Comment